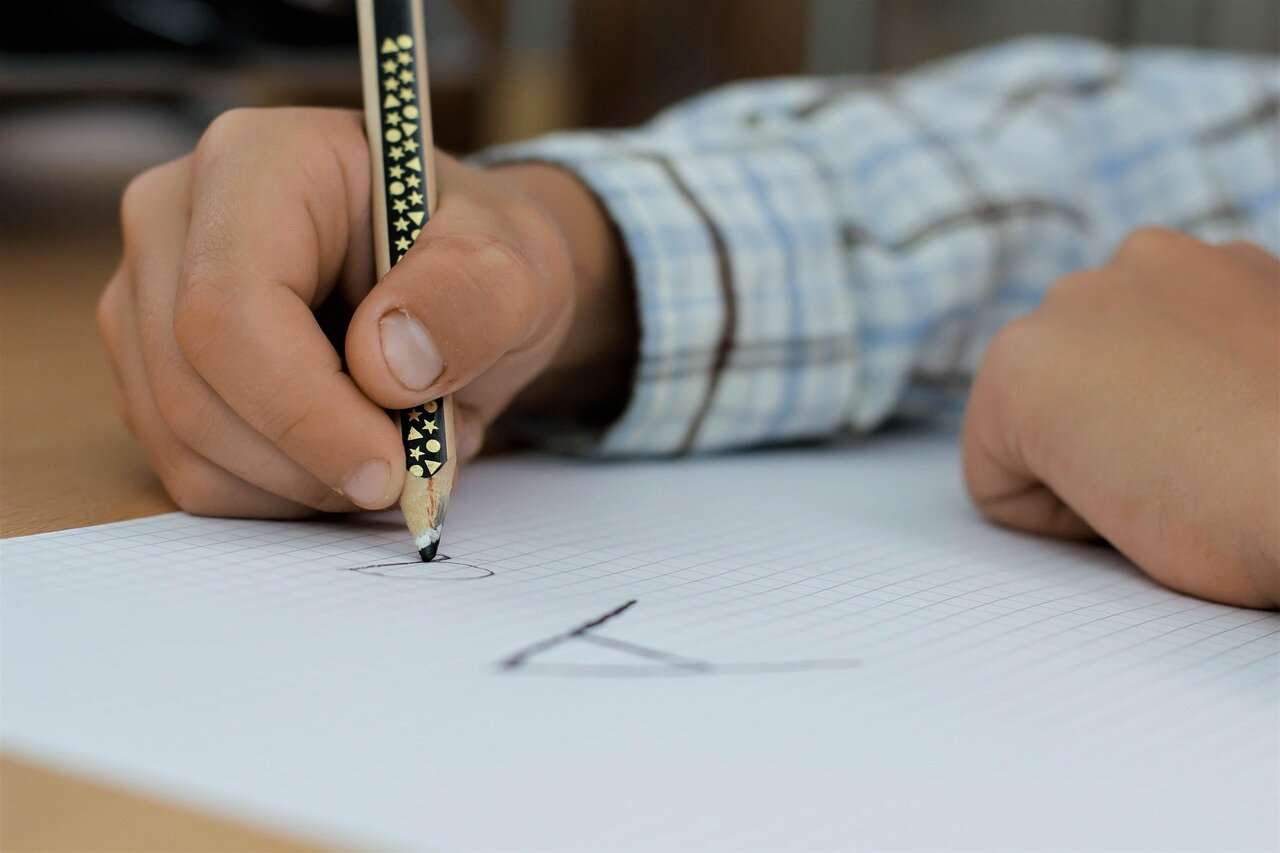Negli ultimi giorni, la cronaca locale ci ha scossi con la notizia di un violento pestaggio avvenuto a Marina di Carrara, dove un giovane è stato aggredito da alcuni coetanei.
Episodi come questo lasciano un senso di smarrimento e ci costringono a fermarci a riflettere.
Come è possibile che ragazzi così giovani possano trasformare la rabbia in violenza fisica? Cosa accade nel mondo emotivo degli adolescenti di oggi, e cosa possiamo fare come adulti per accompagnarli in modo più consapevole?
Molti adolescenti vivono un conflitto interno tra ciò che sentono e ciò che riescono a esprimere. La rabbia, in questi casi, è spesso la superficie visibile di qualcosa di più profondo: insicurezze, paure, bisogno di riconoscimento o di controllo.
Quando un ragazzo non ha parole per dire ciò che prova, le emozioni cercano altre vie per farsi sentire, e a volte diventano gesti impulsivi, oppositivi o distruttivi.
La violenza non è “il problema” in sé, ma il modo in cui un problema non riconosciuto si manifesta.
Come psicologa clinica dell’infanzia e dell’adolescenza, mi capita spesso di incontrare genitori spaventati da comportamenti aggressivi dei figli.
Dico loro che il primo passo non è punire, ma comprendere. Dietro un atto impulsivo può esserci un bisogno di vicinanza, di limiti chiari, o semplicemente di essere visti. Gli adulti, di fronte a comportamenti difficili, spesso reagiscono con la stessa emozione che ricevono: rabbia contro rabbia, chiusura contro chiusura. Ma ciò di cui i ragazzi hanno davvero bisogno è uno spazio di ascolto non giudicante, dove possano sentirsi accolti anche quando sbagliano.
La prevenzione della violenza passa attraverso l’educazione emotiva.
È fondamentale che scuola, famiglia e contesti sportivi o sociali diventino luoghi in cui i ragazzi imparano a riconoscere e gestire le proprie emozioni. Non si tratta di insegnare a non arrabbiarsi, ma di capire cosa c’è dietro la propria rabbia. Un ragazzo che sa nominare la frustrazione, chiedere aiuto o riconoscere un limite, avrà molte meno probabilità di trasformare il suo disagio in aggressività.
Nessun adolescente cresce da solo. Dietro ogni storia di disagio c’è quasi sempre una rete che si è allentata: famiglie in difficoltà comunicativa, scuole sovraccariche, mancanza di spazi di ascolto.
È importante che genitori, insegnanti e professionisti collaborino, condividendo strumenti e osservazioni, senza delegare né colpevolizzare. La psicologia, in questo senso, non è solo un intervento terapeutico dopo un episodio, ma può diventare uno spazio di prevenzione, supporto e formazione alla relazione.
Il pestaggio di Marina di Carrara, come tanti altri episodi simili, non deve lasciarci solo indignati, ma più consapevoli.
Lavorare con gli adolescenti significa restare accanto a loro proprio quando sembrano respingerci, aiutarli a dare nome alle emozioni, insegnare che chiedere aiuto non è un segno di debolezza ma di forza.
Come psicologa, credo che ogni comunità – la scuola, la famiglia, il territorio – possa diventare parte della cura. Parlare di questi temi, oggi, è già il primo modo per prevenire.